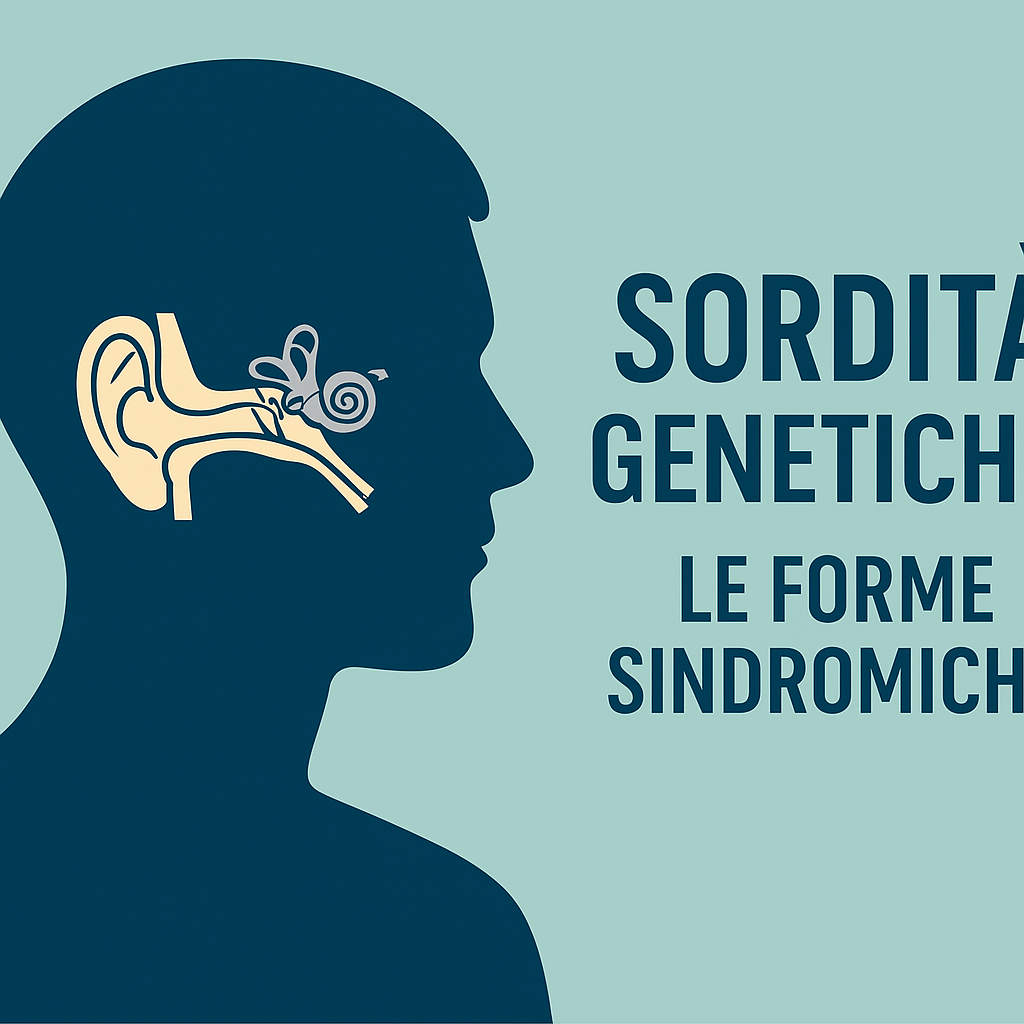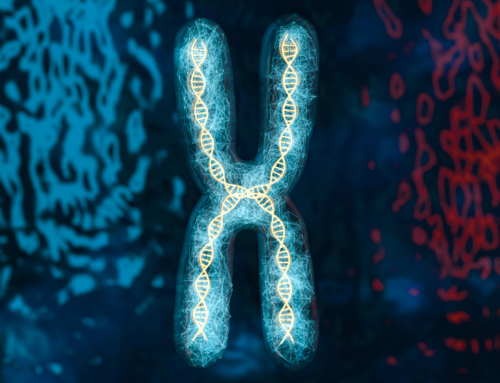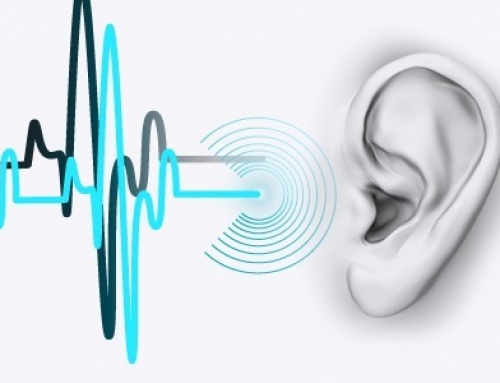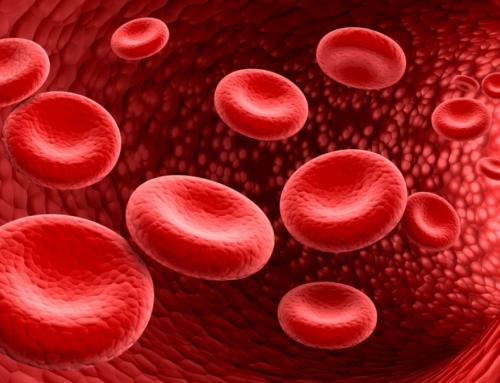A cura di Cristina Gorgone – Medico Genetista
Le sordità sindromiche rappresentano circa il 30% delle forme genetiche di ipoacusia. Si caratterizzano per grande variabilità clinica e ad oggi sono note oltre 400 sindromi associate a perdita dell’udito. Il loro riconoscimento è molto importante, in quanto una corretta diagnosi nelle fasi iniziali può influenzare la condotta terapeutica-riabilitativa da seguire.
Anche qui, come nelle forme non sindromiche, la classificazione prende in considerazione la modalità di trasmissione, distinguendo quindi forme autosomiche dominanti, autosomiche, recessive, X linked e mitocondriali.
Sindromi a trasmissione autosomica recessiva
Tra le forme autosomiche recessive le più frequenti sono:
- La sindrome di Jervell e Lange Nielsen è una sindrome familiare del QT lungo rara e grave, caratterizzata da sordità neurosensoriale profonda bilaterale congenita, intervallo QT lungo all’elettrocardiogramma e tachiaritmie ventricolari potenzialmente letali. I geni coinvolti sono KCNQ1 e KCNE1. La malattia è molto rara. La prevalenza non è nota e varia nelle diverse popolazioni (1/100.000-1/1.000.000). Circa il 50% dei pazienti sviluppa i sintomi della malattia prima dei tre anni. Di solito la malattia si manifesta in un bambino con sordità congenita che presenta episodi di sincope durante i periodi di stress, in caso di esercizio fisico o di paura. La sordità è congenita, bilaterale, profonda e neurosensoriale. L’intervallo QT di solito è molto allungato (>500 ms) e si associa a tachiaritmie (tachicardia ventricolare, episodi di tachicardia ventricolare con torsione della punta [TdP] e fibrillazione ventricolare), che possono causare sincope o morte improvvisa.
- La sindrome di Usher è una ciliopatia rara caratterizzata da sordità neurosensoriale congenita o ad esordio infantile associata alla retinite pigmentosa (RP) che si manifesta successivamente con cecità notturna e perdita progressiva della vista e, in alcuni pazienti, con disfunzione vestibolare. La prevalenza è stimata in 1/30.000. Si tratta della causa più comune di sordità associata alla cecità ereditaria.
Di solito la sordità neurosensoriale è congenita. A seconda della gravità della sordità, si distinguono tre forme cliniche della malattia: il tipo 1 (circa il 40% dei casi), caratterizzato da sordità congenita profonda, non progressiva, di solito associata ad areflessia vestibolare che causa un ritardo dello sviluppo; il tipo 2 (circa il 60% dei casi), caratterizzato dalla sordità congenita moderata-grave a progressione lenta, non associata ad anomalie vestibolari; il tipo 3 (meno del 3% dei casi) caratterizzato dalla sordità a progressione rapida, di solito diagnosticata nella prima decade di vita, associata, nella metà dei pazienti, ad anomalie vestibolari.
La retinite pigmentosa esordisce successivamente, di solito nella seconda o terza decade di vita, con la caratteristica visione notturna e la compromissione progressiva del campo visivo periferico. La cecità notturna si manifesta nella prima infanzia. L’unico fenotipo retinico è la distrofia dei coni e dei bastoncelli. L’edema maculare può compromettere la visione centrale. Spesso i pazienti presentano cataratta prima dei 50 anni.
Ad oggi sono state individuate alcune mutazioni in cinque geni (MYO7A, USH1C, CDH23, PCDH15, USH1G), responsabili della USH tipo 1. Le mutazioni nei tre geni USH2A, ADGRV1 e WHRN causano la USH tipo 2. Il tipo 3 è causato da mutazioni nel gene CLRN1.
- La sindrome di Pendred (PDS) è una sordità genetica sindromica con un quadro clinico variabile, caratterizzata da sordità neurosensoriale bilaterale e gozzo eutiroideo. La PDS è una delle forme più frequenti di sordità genetica sindromica. La prevalenza non è nota, ma potrebbe rappresentare il 7,5% di tutti i casi di sordità congenita. Il quadro clinico della malattia è molto variabile, anche all’interno della stessa famiglia. Il principale segno d’esordio è la sordità neurosensoriale prelinguale. Il grado della sordità è variabile, potendo essere lieve-moderato e progressivo, o grave-profondo. Nella metà circa dei pazienti sono state individuate mutazioni eterozigoti bialleliche o doppie: mutazioni bialleliche in SLC26A4, o mutazioni eterozigoti doppie in SLC26A4 e FOXI1, o in SLC26A4 e KCNJ10. Quasi tutte le mutazioni individuate in SLC26A4 sono bialleliche e interessano la proteina codificata, la pendrina, uno scambiatore anionico multifunzionale. Meno dell’1% dei pazienti presenta doppie mutazioni eterozigoti.
Sindromi a trasmissione autosomica dominante
Tra le forme autosomiche dominanti le più frequenti sono:
- Otosclerosi: è una malattia ereditaria progressiva che colpisce la capsula ossea di rivestimento dell’orecchio interno. Comincia a manifestarsi tra i 20 e i 40 anni, con riduzione dell’udito. Le cause della malattia non sono ancora state chiaramente identificate. Probabilmente, sono coinvolti sia aspetti genetici sia aspetti ambientali.
- Sindrome di Treacher-Collins: è una malattia congenita dello sviluppo craniofacciale caratterizzata da displasia otomandibolare bilaterale e simmetrica, senza anomalie degli arti, associata a diverse anomalie della testa e del collo. L’incidenza annuale è stimata in 1/50.000 nati vivi. I bambini presentano dismorfismi facciali caratteristici, con ipoplasia bilaterale e simmetrica delle ossa zigomatiche e del bordo infra-orbitale (80% dei casi) o della mandibola (78%; retrognazia, retrogenia), che comporta una malocclusione dentale, caratterizzata spesso da un morso mandibolare aperto anteriormente.. Sono spesso presenti anomalie dell’orecchio esterno (60%), compresa l’anotia o la microtia, l’atresia dei condotti uditivi esterni e le anomalie della catena degli ossicini, che esitano in una sordità di conduzione. La sindrome è dovuta alle mutazioni del gene TCOF1 che codifica per la fosfoproteina nucleolare Treacle, o dei geni POLR1C e POLR1D, che codificano per le subunità delle RNA polimerasi I e III.
- Sindrome brachio-oto-renale: è caratterizzata da anomalie degli archi branchiali (schisi, fistole, cisti), difetti dell’udito (malformazioni dei padiglioni auricolari con fistole preauricolari, sordità di conduzione o neurosensoriale) e anomalie renali (malformazioni delle vie urinarie, ipoplasia o agenesia renale, displasia renale, cisti renali). La prevalenza è 1/40.000. La patologia dei reni può esitare in insufficienza renale cronica. L’espressione della malattia varia nelle diverse famiglie e tra le persone affette della stessa famiglia. Alcune famiglie non presentano anomalie renali o delle vie urinarie.
Il gene-malattia è EYA1. In circa il 40% delle persone affette sono state identificate mutazioni puntiformi e delezioni. Sono state anche identificate le mutazioni dei geni SIX1 e SIX5, i cui prodotti interagiscono con EYA1 in quanto i complessi formati sono fattori di trascrizione.
- Neurofibromatosi 2: è una malattia da predisposizione ai tumori ed è caratterizzata dallo sviluppo di schwannomi e meningiomi multipli. La prevalenza (inizialmente stimata in 1 ogni 200.000) è circa 1 ogni 60.000. Le persone affette sviluppano inevitabilmente degli schwannomi che interessano entrambi i nervi vestibolari conducendo alla sordità. La maggior parte dei pazienti presenta una sordità, di solito unilaterale all’esordio, che può essere accompagnata o preceduta da tinnito. Gli schwannomi vestibolari che si presentano come primo sintomo possono causare capogiri e perdita dell’equilibrio. È dovuta a mutazioni del gene NF2 localizzato sul cromosoma 22
- Sindrome di Stickler: è una vitreo-retinopatia caratterizzata dall’associazione tra segni oculari, correlati alle forme più o meno complete della sequenza di Pierre Robin, alterazioni scheletriche e sordità neurosensoriale (10% dei casi). L’incidenza è stimata in circa 1 ogni 7.500 neonati. I disturbi oculari comprendono la cataratta giovanile, la miopia, lo strabismo, la degenerazione vitreo-retinica o corio-retinica, il distacco della retina e l’uveite cronica. La lassità articolare giovanile è seguita da segni precoci di artrosi. Sembra che la sindrome sia trasmessa di solito come carattere autosomico dominante e sia geneticamente eterogenea. La sindrome di Stickler tipo 1 è dovuta alle mutazioni del gene COL2A1, quella tipo 2 alle mutazioni dei geni COL11A1 e COL11A2.
- Sindrome di Waardenburg: è una malattia caratterizzata da sordità di grado variabile e difetti minori delle strutture che originano dalla cresta neurale, che causano anomalie della pigmentazione degli occhi, dei capelli e della pelle. La WS comprende quattro fenotipi clinici e genetici diversi. L’incidenza mondiale è stimata in circa 1/40.000. La sindrome di Waardenburg (WS) tipo 1 (WS1) e tipo 2 (WS2) sono le forme più comuni; il tipo 3 (WS3) e il tipo 4 (WS4) sono più rari; sono stati descritti solo pochi casi di WS3. La WS è responsabile di circa il 3% di tutti i casi istituzionalizzati di sordità congenita.
La WS è una malattia geneticamente eterogenea. Sono state identificate mutazioni in 6 diversi geni: PAX3, MITF, SNAI2, SOX10, EDNRB e EDN3. Le mutazioni in PAX3 si associano alla WS1 e alla WS3, mentre le mutazioni nel gene MITF si associano alla WS2.
Sindromi a trasmissione X-Linked
Tra le forme a trasmissione X-Linked le più frequenti sono:
- Sindrome di Wildervanck: è caratterizzata dalla triade: fusione delle vertebre cervicali (anomalia di Klippel-Feil), paralisi bilaterale del nervo abducente (sindrome di Duane) e sordità neurosensoriale congenita. Occasionalmente sono stati osservati la sublussazione bilaterale del cristallino, la paralisi facciale, il difetto del setto atriale, la scoliosi e la colelitiasi. È probabile un’eredità multifattoriale; è stata discussa la possibile eredità dominante legata al sesso, con letalità nei maschi emizigoti. Non è stato identificato il gene-malattia.
- Sindrome palato-oto-digitale 1 e 2: il tipo 1 (OPD1) è la forma più lieve della sindrome oto-palato-digitale, ed è caratterizzata da displasia scheletrica generalizzata, disabilità intellettiva lieve, sordità di conduzione e dismorfismi facciali caratteristici. La OPD1 è una malattia congenita caratterizzata da displasia scheletrica generalizzata e malformazioni degli ossicini dell’orecchio che, in alcuni pazienti, causano la sordità di conduzione. La OPD1 è causata da mutazioni con guadagno di funzione nel gene FLNA, che codifica la filamina A. Il tipo 2 è una forma grave della sindrome oto-palato-digitale, ed è caratterizzata da dismorfismi facciali, displasia scheletrica grave, anomalie extrascheletriche e prognosi sfavorevole. La OPD2 è causata da mutazioni con guadagno di funzione nel gene FLNA (Xq28), che codifica la filamina A
- Sindrome di Norrie: Si tratta di un difetto raro dello sviluppo dell’embrione, caratterizzato da anomalie della retina e cecità congenita. In genere si associa a sordità neurosensoriale, ritardo dello sviluppo, disabilità intellettiva e/o disturbi comportamentali. I pazienti sono quasi sempre maschi. Di solito i segni oculari nei maschi affetti sono bilaterali e simmetrici. La maggior parte dei maschi affetti sviluppa sordità neurosensoriale asimmetrica progressiva ad esordio infantile (l’età media all’esordio è 12 anni). Nell’età adulta intermedia, la sordità può essere grave e bilaterale. In circa il 20-30% dei pazienti, si osserva ritardo dello sviluppo e disabilità intellettiva. La malattia è causata da mutazioni nel gene NDP, che codifica per la norrina, coinvolta nello sviluppo vascolare dell’occhio e dell’orecchio.
- Sindrome di Alport: è una malattia renale rara caratterizzata da nefropatia glomerulare con ematuria, che progredisce verso la malattia renale terminale (ESRD), spesso associata a sordità neurosensoriale e, occasionalmente, ad anomalie oculari. La malattia è suddivisa in tre sottotipi clinici: AS legata all’X (XL), AS autosomica recessiva (AR) e AS autosomica dominante (AD), che rappresentano, rispettivamente, circa l’80%, il 15% e il 5% dei casi di AS. La malattia può esordire in ogni momento tra l’infanzia e l’età avanzata, anche se in genere l’esordio delle forme XL e AR è più precoce (infanzia o adolescenza).
La sordità neurosensoriale è comune.
La AS è causata da un difetto strutturale del collagene tipo IV, una componente essenziale della membrana basale glomerulare. La forma XL è causata da mutazioni nel gene COL4A5, che codifica la catena alfa 5 del collagene di tipo IV. Le forme AR e AD sono causate dalle mutazioni dei geni COL4A3 e COL4A4, che codificano, rispettivamente, le catene alfa 3 e 4 del collagene di tipo IV. La XL-DLAS è causata dalle mutazioni dei geni COL4A5 e COL4A6.
H2: Sindromi a trasmissione mitocondriali
Tra le forme a trasmissione mitocondriale le più frequenti sono:
- MELAS: Si tratta di una malattia neurometabolica genetica rara, progressiva e multisistemica, causata da una disfunzione mitocondriale, caratterizzata da encefalomiopatia, acidosi lattica ed episodi simil-ictus. Si tratta di una delle malattie mitocondriali più comuni, che si stima colpiscano 1/10.000 individui. I maschi e le femmine sono colpiti in uguale misura. È una malattia multiorgano, caratterizzata da segni clinici variabili, che di solito esordiscono prima dei vent’anni, ma che possono manifestarsi ad ogni età. Il segno clinico distintivo sono gli episodi simil-ictus. Altri segni clinici sono l’endocrinopatia (il diabete, per lo più di tipo 2 e solo occasionalmente di tipo 1, e l’ipo/ipertiroidismo), la polineuropatia, la cardiomiopatia, la sordità neurosensoriale e la pseudo-ostruzione intestinale.
Tra le mutazioni finora individuate in 19 geni mitocondriali, la più comune (circa 80% dei casi) è la mutazione 3243G>A nel gene del tRNA mitocondriale Leu (UUR).
- Sindrome di Kearns-Sayre: è un raro errore congenito del metabolismo, caratterizzato da oftalmoplegia esterna progressiva (PEO) e retinite pigmentosa, che esordiscono prima dei vent’anni di età. Altri segni clinici comuni sono la sordità, l’atassia cerebellare e il blocco cardiaco. La prevalenza non è nota, ma è stata stimata in 1/125.000.
Spesso la malattia esordisce durante l’infanzia con i sintomi oculari caratteristici, che comprendono la ptosi, la retinopatia pigmentata e la PEO, seguiti dalla progressiva insorgenza di altri segni clinici, che dipendono dalla distribuzione nei tessuti della variante molecolare. I segni clinici più comuni sono la sordità neurosensoriale bilaterale, le cardiopatie (cardiomiopatia, difetti della conduzione cardiaca), l’interessamento del sistema nervoso centrale (atassia cerebellare, disartria, debolezza facciale bilaterale, deficit cognitivo), la miopatia dei muscoli scheletrici, le malattie intestinali ed endocrine (ritardo della pubertà, ipoparatiroidismo, diabete) e l’insufficienza renale.
La KSS è causata dalle delezioni di ampie porzioni del DNA mitocondriale (mtDNA).
- Sindrome MIDD: si tratta di un sottotipo di diabete (1%), diagnosticato attorno ai 37 anni di vita associato a ipoacusia neurosensoriale. La perdita dell’udito precede il diabete. È dovuto ad una mutazione puntiforme alla posizione 3243 del DNA mitocondriale.
- MERRF: La sindrome MERRF (epilessia mioclonica con fibre rosse sfilacciate) è un’encefalomiopatia mitocondriale, caratterizzata da crisi epilettiche miocloniche. I pazienti di solito presentano epilessia mioclonica durante l’adolescenza o all’inizio della vita adulta, in associazione, talvolta, a sordità neurosensoriale, atrofia ottica, bassa statura o neuropatia periferica. La malattia è progressiva, con peggioramento dell’epilessia.
La sindrome MERRF è causata da mutazioni nel DNA mitocondriale. Più dell’80% dei pazienti presenta la mutazione 8344A>G nel gene che codifica per l’RNA di trasporto della lisina (MTTK). Sono state identificate anche altre mutazioni in altri geni che codificano per l’RNA di trasporto e nel gene MTND5.
- Cheratodermia palmoplantare-sordità: è un cheratoderma palmoplantare raro, ereditario, diffuso e mutilante, caratterizzato da grave cheratosi palmoplantare a nido d’ape e pseudo-ainhum delle dita, che esita nell’autoamputazione. Si associa a sordità neurosensoriale congenita lieve-moderata. Altri segni clinici sono la cheratosi stellata sulle superfici estensorie delle dita, dei piedi, dei gomiti e delle ginocchia. Può associarsi ad alopecia, onicogriposi, distrofia ungueale o ippocratismo, paraplegia spastica e miopatia.
Sindromi a trasmissione non nota
Tra le forme a trasmissione non nota le più frequenti sono:
- Sindrome brachiooculofacciale: è caratterizzata da un basso peso alla nascita e ritardo di crescita, schisi branchiali bilaterali che possono essere emangiomatose, occasionali lesioni della cute dietro le orecchie (lesioni simili a quelle prodotte da un’ustione), strabismo congenito, dotti nasolacrimali ostruiti, dismorfie, padiglioni auricolari malformati, la sordità di conduzione o neurosensoriale, le fossette preauricolari e labiali, il palato ogivale, le anomalie dei denti, le anomalie oculari (coloboma, microftalmia), e le cisti sottocutanee a livello del cuoio capelluto.
La BOFS è causata da mutazioni che coinvolgono il gene TFAP2A. Anche se alcuni casi sono sporadici, la maggior parte dei casi descritti è familiare.
- Sindrome CHARGE: è stata inizialmente definita come una associazione non casuale di anomalie (Coloboma, Difetti cardiaci, Atresia delle coane, Ritardo di crescita e sviluppo, Ipoplasia dei genitali, Anomalie delle orecchie/Sordità). Le anomalie delle orecchie includono la caratteristica classica di orecchie di forma inusuale e perdita dell’udito (sordità conduttiva e/o nervosa che varia da lieve a grave). In oltre il 75% dei pazienti con sindrome CHARGE sono state identificate mutazioni nel gene CHD7.
- Sindrome di Goldenhar: anche nota come displasia oculo-auricolo-vertebrale o microsomia emifacciale, è una rara malattia congenita caratterizzata tipicamente dalla presenza di cranio e viso di ridotte dimensioni (con microsomia emifacciale), cisti dermoidi oculari e malformazioni della colonna vertebrale. Possono essere presenti anche alterazioni del naso, dell’orecchio, della mandibola, delle labbra e del palato molle, nonché disabilità intellettiva e paralisi periferica del nervo facciale e alterazioni cardiovascolari, gastrointestinali e genito-urinarie. È associata a un anomalo sviluppo del primo e del secondo arco faringeo.
Bibliografia
Martin Lewis , Caroline D Robson, Felice D’Arco. Syndromic Hearing Loss in Children Neuroimaging Clin N Am 2023 Nov;33(4):563-580. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37741658/
C Dorbeau , W Bijou, D Bakhos. Syndromic hearing loss Eur Ann Otorhinolaryngol Head Neck Dis 2021 Mar;138(2):118-119. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32912813/
Geoffrey Casazza, Jeremy D Meier. Evaluation and management of syndromic congenital hearing loss. Curr Opin Otolaryngol Head Neck Surg 2017 Oct;25(5):378-384. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28697000/