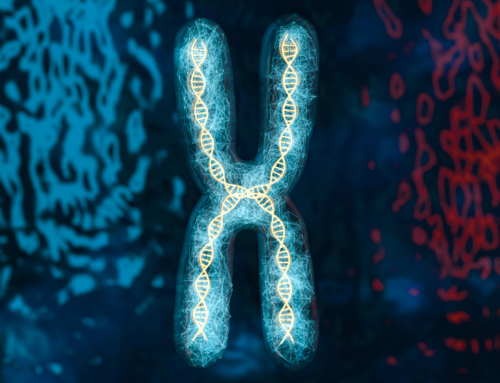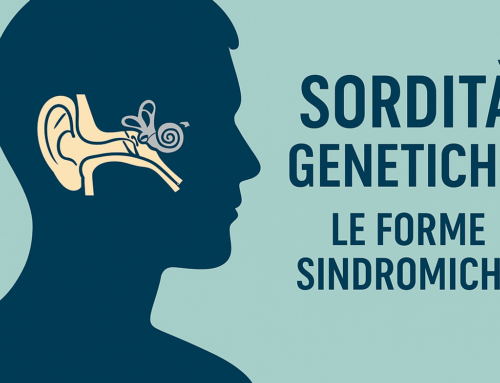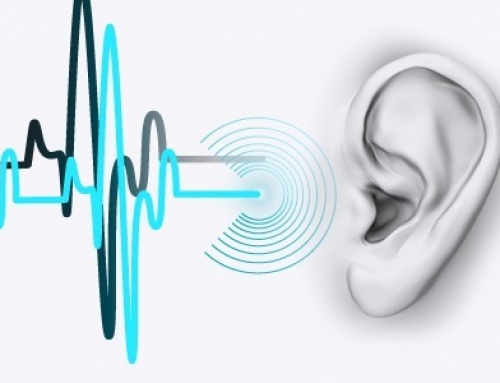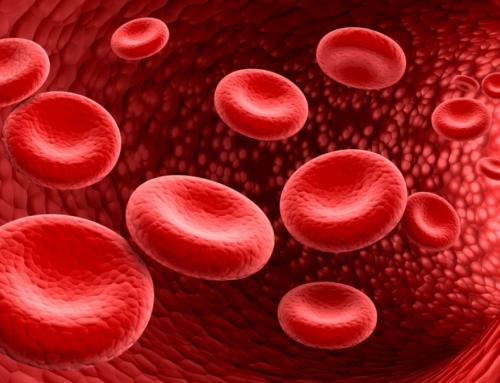A cura di Cristina Gorgone – Medico Genetista
Le sordità genetiche non sindromiche nella maggioranza dei casi sono patologie “monogeniche”: ovvero l’alterazione di un singolo gene è responsabile di ciascuna forma di sordità.
Una convenzione internazionale ha stabilito di denominare i loci della sordità non sindromica con le sigle DFNA (deafness, autosomica dominante), DFNB (deafness, autosomica recessiva), e DFN (deafness, X-linked) a seconda delle modalità di trasmissione. Tali sigle sono seguite da un numero, che definisce l’ordine di tempo nel quale ogni forma è stata riconosciuta. Ad oggi esistono 60 forme DFNA, 80 forme DFNB, e 5 forme DFN. Oltre a queste, nella classificazione sono state inserite 2 forme DFNM, (M modificante) caratterizzate dalla presenza di un gene “modificante”, cioè in grado di cambiare l’espressività di una determinata variante genetica.
Le relazioni fra geni, fenotipo, e modalità di trasmissione del carattere sono complesse secondo il tipo di variante: così uno stesso gene può determinare una DFNA e/o una DFNB, e/o una sordità sindromica.
Geni coinvolti: la Connessina 26 (GJB2)
La forma più frequente è quella determinata dal gene Connessina 26 (GJB2), responsabile di circa l’80% di forme di sordità non sindromica a trasmissione autosomica recessiva.
Le connessine sono una famiglia di proteine di membrana largamente espresse nell’organismo umano (finora ne sono stati identificati più 20 tipi diversi): ogni connessina è costituita da quattro domini transmembrana con due loops extracellulari ed uno citoplasmatico e si combina in esameri formare un complesso che viene definito connessone. Ogni connessone, a sua volta, interagisce con un altro connessone di una cellula adiacente per formare canali intercellulari o gap junctions: tali strutture sono molto importanti per gli scambi di elettroliti, secondi messaggeri e metaboliti
La connessina 26 è essenziale per il funzionamento della coclea: la sua assenza, infatti, determina una mancata trasmissione dell’impulso nervoso, determinando una ipoacusia neurosensoriale congenita.
Le varianti di tale gene, localizzato sul braccio lungo del cromosoma 13, determinano due forme di ipoacusia: la DFBN1, la più frequente, e la DFNA3, più rara e a trasmissione autosomica dominante.
La forma autosomica recessiva si caratterizza per perdita dell’udito, bilaterale, isolata, prelinguale da lieve a profonda con variabilità sia inter- che intrafamiliare. La sordità è raramente progressiva e può riguardare le alte frequenze o tutte le frequenze con la stessa gravità.
Nel gene della connessina 26 sono state descritte oltre 100 varianti differenti e numerosi polimorfismi. Nelle popolazioni caucasiche la variante più frequente è la 35delG, che causa un codone di stop prematuro della sintesi della proteina. Si stima che in Italia circa una persona su 30-35 nella popolazione è eterozigote (portatore sano) per una mutazione del gene della connessina 26.
Geni coinvolti: il gene OTOF
Altro gene coinvolto in una forma recessiva di sordità è il gene OTOF, responsabile della forma DFNB9.
L’otoferlina è una proteina che interviene nella regolazione delle vescicole presinaptiche delle cellule cigliate interne. La sordità è prelinguale di grado severo- profondo. La particolarità di questa forma di sordità è che essa può presentarsi come una neuropatia auditiva, con otoemissioni acustiche OAE inizialmente conservate e ABR assente.
Il gene OTOF si trova sul braccio corto del cromosoma 2 alla posizione 23.1: sono state identificate almeno 16 varianti nel gene OTOF nei pazienti con una forma di sordità non sindromica.
Geni coinvolti: il gene COCH
Tra le sordità non sindromiche autosomiche dominanti la più nota è quella dovuta a varianti del gene COCH, responsabile di DFNA9.
Il gene COCH fornisce istruzioni per formare una proteina chiamata Cochlin. Questa proteina è abbondante a livello della coclea e nel sistema vestibolare. Sebbene il ruolo esatto della proteina Cochlin rimanga sconosciuto, probabilmente gioca un ruolo fondamentale nella struttura dell’orecchio interno.
DFNA9 determina una forma di ipoacusia neurosensoriale associa a disfunzione vestibolare ad insorgenza nell’età adulta. Si tratta di una forma progressiva che inizialmente interessa soprattutto le alte frequenze e che comporta anche disturbi dell’equilibrio con vertigini.
Il gene è stato identificato tramite studi di linkage ed è localizzato nel braccio lungo del cromosoma 14. La funzione del gene COCH non è ancora del tutto nota, ma nell’orecchio interno delle persone affette sono stati evidenziati depositi di mucopolisaccaridi probabile causa della degenerazione delle fibre nervose.
Geni coinvolti: il gene POU3F4
Tra le forme X linked, la forma di ipoacusia più frequente è quella dovuta a varianti del gene POU3F4.
Il gene codifica per POU3F4 un fattore di trascrizione che limita il potenziale di proliferazione delle cellule staminali neurali, è quindi coinvolto nello sviluppo del sistema nervoso.
Nella maggiorparte dei casi si manifesta come sordità neurosensoriale con un’epoca di esordio variabile, potendosi sviluppare alla nascita, in età infantile o nella seconda decade.
Talvolta, tale sordità è di tipo misto, con una quota trasmissiva rilevante, dovuta a una condizione di fissità della staffa e ad un aumento della pressione deli liquidi endococleari. Come conseguenza, c’è una comunicazione tra lo spazio subaracnoideo nel meato uditivo interno e la perilinfa nella coclea, che comporta un’accresciuta pressione perilinfatica. Si ritiene che questa pressione aumentata sia alla base del fenomeno di “gusher” che consiste nell’improvvisa fuoriuscita di liquido endococleare durante un intervento di stapedectomia, con conseguente comparsa di ipoacusia neurosensoriale profonda.
Essendo la patologia a trasmissione X linked, nelle donne portatrici della variante le manifestazioni cliniche sono presenti in forma più lieve sia nell’aspetto malformativo che nella perdita uditiva.
Bibliografia
Fatemeh Azadegan-Dehkord, Reza Ahmadi, Mahbobeh Koohiyan, Morteza Hashemzadeh-Chaleshtori. Update of spectrum c.35delG and c.-23+1G>A mutations on the GJB2 gene in individuals with autosomal recessive nonsyndromic hearing loss Ann Hum Genet 2019 Jan;83(1):1-10. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30175840/
Pey-Yu Chen, Yin-Hung Lin, Tien-Chen Liu, Yi-Hsin Lin, Li-Hui Tseng, Ting-Hua Yang, Pei-Lung Chen, Chen-Chi Wu, Chuan-Jen Hsu. Prediction Model for Audiological Outcomes in Patients With GJB2 Mutations Ear Hear 2020 Jan/Feb;41(1):143-149. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31246659/
Aki Sakata, Akinori Kashio, Misaki Koyama, Shinji Urata, Hajime Koyama, Tatsuya Yamasoba. Hearing and Hearing Loss Progression in Patients with GJB2 Gene Mutations: A Long-Term Follow-Up Int J Mol Sci 2023 Nov 25;24(23):16763. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38069086/
Ignacio Del Castillo, Matías Morín, María Domínguez-Ruiz, Miguel A Moreno-Pelayo. Genetic etiology of non-syndromic hearing loss in Europe Hum Genet 2022 Apr;141(3-4):683-696. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35044523